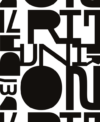IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE e CASTELLO DI MANFREDONIA
Il Museo archeologico nazionale di Manfredonia ha sede all’interno dell’imponente architettura del castello angioino-aragonese.
La nascita del primo nucleo della collezione del Museo è legata alla scoperta delle stele daunie e alla figura di Silvio Ferri, archeologo toscano, che negli anni Sessanta del secolo scorso seguì personalmente il recupero di questi straordinari reperti in pietra, rinvenuti principalmente nelle campagne del territorio sipontino, spesso riutilizzati nei muretti a secco e nei pavimenti delle stalle. La sua opera di sensibilizzazione sul territorio, affinché i reperti venissero trasferiti al castello e adeguatamente valorizzati, si concluse positivamente nel 1968 con la donazione del Castello allo Stato italiano.
Nel 1980 venne realizzato il primo allestimento per l’esposizione delle stele daunie e fu organizzata la prima apertura al pubblico. Il Museo ospita, oggi, la più importante collezione di stele daunie al mondo.
Il percorso espositivo segue un criterio cronologico che si snoda in quattro sale principali, arricchite da spazi di approfondimento dedicati a rinvenimenti particolarmente importanti del territorio della Puglia settentrionale, dalla Preistoria alla fine dell’età arcaica.
Al primo piano sono presenti due sale: una dedicata alla Preistoria (sala 1) e l’altra all’età del Bronzo (sala 2, Metropoli dell’età del Bronzo).
La prima sezione della Sala 1 racconta gli aspetti principali del Neolitico nel Nord della Puglia; un breve sguardo è rivolto qui all’introduzione, nel corso del VII millennio a.C., di un’economia basata sulla capacità di produrre il cibo. In questo periodo, si sperimentano le prime forme di coltivazione di cereali e di allevamento, con la nascita, nel Tavoliere di Puglia, dei primi stabili villaggi all’aperto, circondati da fossati concentrici (Masseria Candelaro, Passo di Corvo, Monte Aquilone, Ripa Tetta).
Risale al Neolitico anche la produzione di ceramica per conservare, cuocere e consumare i cibi, la diffusione della tecnica di estrazione della selce, la lavorazione della pietra levigata e delle materie dure animali (osso e corno), temi a cui sono dedicati diversi approfondimenti lungo il percorso di visita. Vengono raccontati inoltre alcuni aspetti legati al mondo di credenze delle comunità neolitiche, come le statuine femminili, le rappresentazioni di volti umani sui vasi, le pintaderas.
L’ultima sezione si conclude con l’età del Rame, o Eneolitico, periodo in cui i principali cambiamenti sono legati all’introduzione del rame e soprattutto allo sviluppo di aspetti ideologici e rituali funerari via via più articolati. Le deposizioni erano accompagnate spesso da ricchi corredi e la presenza di armi sembra voler sottolineare il ruolo di guerriero svolto in vita dal defunto.
Il percorso di visita prosegue nella sala 2, con le principali testimonianze dell’età del Bronzo, un periodo che si estende dal 2300 al 1000 a.C. e segna l’inizio della Protostoria. In questo lungo arco di tempo si attuarono profondi cambiamenti e si produssero fondamentali innovazioni, legate soprattutto alla scoperta della metallurgia del bronzo, lega metallica di rame e stagno di straordinaria resistenza. La necessità di approvvigionarsi delle nuove materie prime favorì commerci su vasta scala verso il Mediterraneo e l’Europa come testimoniato soprattutto dal rinvenimento di ceramiche di produzione egea e di ambra proveniente dal Mar Baltico. Tra i cambiamenti più importanti nel modo di abitare, si assiste alla nascita a partire dal Bronzo medio di grandi insediamenti fortificati, tra cui Coppa Nevigata, uno dei siti più noti della Preistoria italiana, a pochi Km ad ovest di Manfredonia, sorto sui margini di un’antica laguna e dotato di un complesso sistema di fortificazioni, con mura in pietrame a secco.
Al piano terra le ultime due sale sono dedicate alla civiltà dei Dauni, la popolazione italica che a partire dal 1000 a.C. circa (tra l’ultima fase del Bronzo finale e l’inizio dell’età del Ferro) abitò un territorio ben più ampio dell’attuale provincia di Foggia, estendendosi, a sud, fino a Canosa di Puglia e, ad est, fino al confine con la Basilicata.
La sala 3, I Dauni. La terra del re straniero, nome che evoca le molteplici versioni mitiche che narrano l’origine dei Dauni, illustra i reperti provenienti dai contesti funerari dei principali centri abitati in età preromana dai Dauni (tra cui Monte Saraceno, Salapia, Cupola-Beccarini, Canosa Toppicelli).
L’ultima sezione del percorso espositivo (sala 4) ospita la più ricca e famosa collezione di stele daunie del mondo, unica nel suo genere per la conoscenza artistica della civiltà daunia. Prodotte prevalentemente nella piana sipontina, a sud di Manfredonia, soprattutto tra VII e VI sec. a.C., queste testimonianze archeologiche sono lastre di pietra dalle stilizzate forme umane, riferibili e personaggi di rango della civiltà daunia, utilizzate come segnacolo di tomba e decorate con incisioni e colorazioni in rosso, nero e giallo. Si distinguono in stele con ornamenti, con un ricco insieme di elementi decorativi della veste funeraria (collane, fibule, pendagli, cinture) e stele con armi, caratterizzate dalla presenza di pettorale, spada e scudo rotondo.
Annalisa Treglia
Direttrice del Museo Nazionale Archeologico e Castello di Manfredonia (FG)