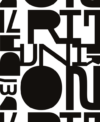IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CANOSA DI PUGLIA
Il Museo Archeologico Nazionale di Canosa è ospitato in un immobile di proprietà privata del XIX secolo, Palazzo Sinesi.
I CRITERI ESPOSITIVI
Canosa è tra i centri della Puglia più ricchi di testimonianze del passato.
L’esposizione attuale illustra uno spaccato della società canosina tra età arcaica ed ellenistica, uno dei momenti di maggior rilevanza nella millenaria storia della città.
Il territorio canosino era occupato sin dall’età del Bronzo e dalla prima età del Ferro tramite gruppi di capanne sparsi tra colline e pianura. La presenza di una vasta necropoli ad incinerazione in località Pozzillo, lungo il corso dell’Ofanto, suggerisce l’esistenza di un villaggio attivo fra il 1400 e il 1200 a.C.
Tra VII e VI secolo a.C. una profonda trasformazione sociale porta alla formazione della civiltà dei Dauni. È il momento della nascita dei principes, capi di clan aristocratici, detentori di ruoli egemoni nella collettività. A Canosa in località Toppicelli un gruppo socialmente rilevante costruisce un piccolo insediamento con abitazioni, fornaci e sepolture principesche. Altre aree di abitato, caratterizzate da elementi culturali coerenti e unitari, si distribuiscono uniformemente in tutto il territorio.
Dal V secolo a.C. la popolazione si concentra in piccoli nuclei di case sulle colline e i gruppi dominanti consolidano la propria posizione politica ed economica, grazie allo sfruttamento agricolo del territorio- Canosa diventa, insieme ad Arpi, uno dei centri più importanti della Daunia.
I reperti esposti nel Museo provengono dai corredi di tombe arcaiche e ricchi ipogei ellenistici, che testimoniano usanze e mentalità della società canosina e l’elevata qualità dell’artigianato locale tra il VI ed il III secolo a.C.
Nella prima sala dell’Ariete sono esposti i corredi di alcune tombe di VI – V secolo a.C. rinvenute in vico Pasubio e via Legnano, che illustrano le pratiche funerarie tipiche dell’età tardoarcaica riscontrate a Canosa e in altri centri della Daunia
In vico Pasubio, le tombe a fossa scavate nella terra accolgono uno o più defunti, membri dello stesso clan familiare. I corredi sono caratterizzati dalla presenza di ceramica subgeometrica daunia prodotti in officine canosine: grandi contenitori, le olle, e i vasi per attingere, versare e bere che rimandano a forme di convivialità. Il livello sociale dei defunti, pur in assenza di elementi particolarmente pregiati, è testimoniato dalla ripetizione dei vasi e dalla presenza di oggetti d’ornamento e armi.
La tomba di via Legnano si distingue per la presenza di oggetti importati come la coppa ionica che attesta rapporti con le colonie della Magna Grecia, il bacile in bronzo di produzione etrusco campana ed i vaghi di collana in ambra.
Nella seconda sala dei Crateri trovano posto i corredi di alcune deposizioni dell’Ipogeo di Vico san Martino (IV-II sec. a.C.).
La documentazione archeologica più significativa di Canosa in età ellenistica è costituita dalle tombe a camera, utilizzate dalle famiglie dell’élite indigena dall’ultimo trentennio del IV secolo a.C. per sottolineare la propria rilevanza all’interno della comunità.
Si tratta di spazi sepolcrali ipogei ad una o più camere scavati nel banco naturale di tufo, a cui si accedeva tramite un corridoio (dromos) inclinato. Queste strutture funerarie erano destinate a contenere più sepolture della stessa famiglia e ad essere usate per un lungo periodo di tempo.
La maggior parte degli ipogei canosini non è stata oggetto di scavi sistematici, per questo i materiali di corredo pertinenti a sepolture diverse all’interno della stessa struttura sono stati confusi e mescolati.
L’ipogeo di Vico san Martino si distingue per le eccezionali condizioni di ritrovamento, con le tre celle ancora sigillate da grandi lastre, che hanno permesso di riconoscere l’adozione di una originale pratica funeraria, la semicremazione, che prevedeva la parziale combustione del corpo del defunto adagiato accanto ad una pira.
I corredi disposti sul piano delle celle, ideati per ostentare lo status sociale dei defunti, sono composti da ceramica apula a figure rosse e altri beni di prestigio quali armi e metalli.
Le sale successive degli Archeologi, di Niobe, del Naiskos, dei cavalli e delle ceramiche canosine sono dedicate al ricco corredo dell’ipogeo Varrese, una delle più importanti tombe a camera di Canosa, appartenuta per varie generazioni ad una famiglia di spicco del ceto abbiente. Dopo la scoperta fortuita nel 1912, i ricchi corredi rinvenuti nella preziosa tomba furono divisi in due collezioni, che prendono il nome dai proprietari del terreno in cui essa insisteva: la Varrese acquisita dal Museo di Taranto e la Mazza dal Museo di Bari…
Tra i materiali si segnalano, oltre ai vasi apuli a figure rosse caratterizzati da dimensioni monumentali, dalla ricchezza decorativa delle raffigurazioni e dall’impegno narrativo delle scene, un importante nucleo di vasi policromi e plastici detti canosini, decorati con immagini dipinte a tempera con una vasta scelta di colori, tra cui predomina il rosa, e con elementi decorativi applicati.
Anita Rocco
Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia (BT)
*Docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo Classico dei Beni Culturali Cla.Be.C. “E. Fermi” di Canosa di Puglia. Mail: [email protected]. Il presente contributo è la sintesi di una ricerca di approfondimento offerto dallo scrivente agli allievi del primo biennio del Cla.Be.C. nel corso delle lezioni curriculari di Storia e Geografia.